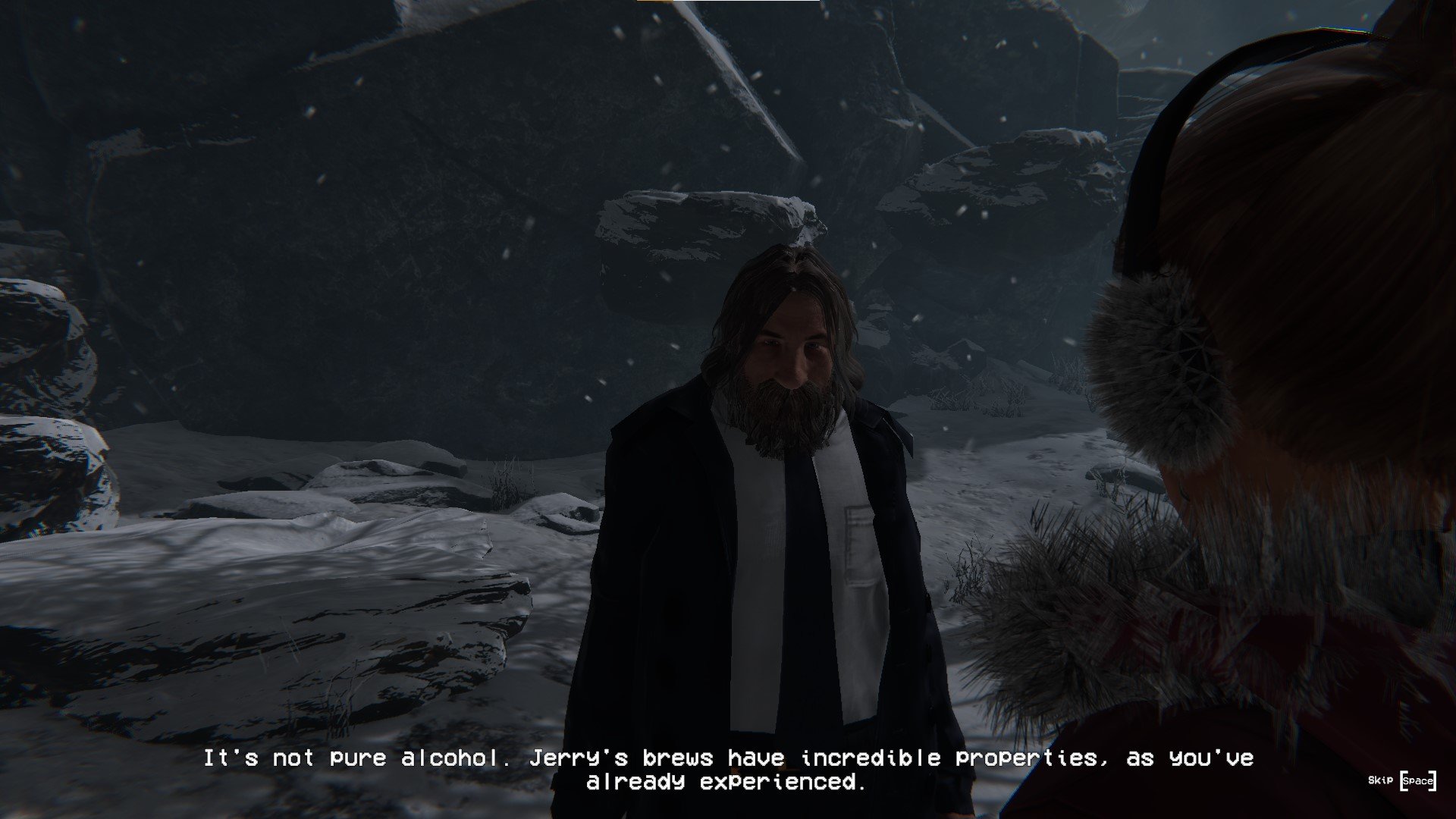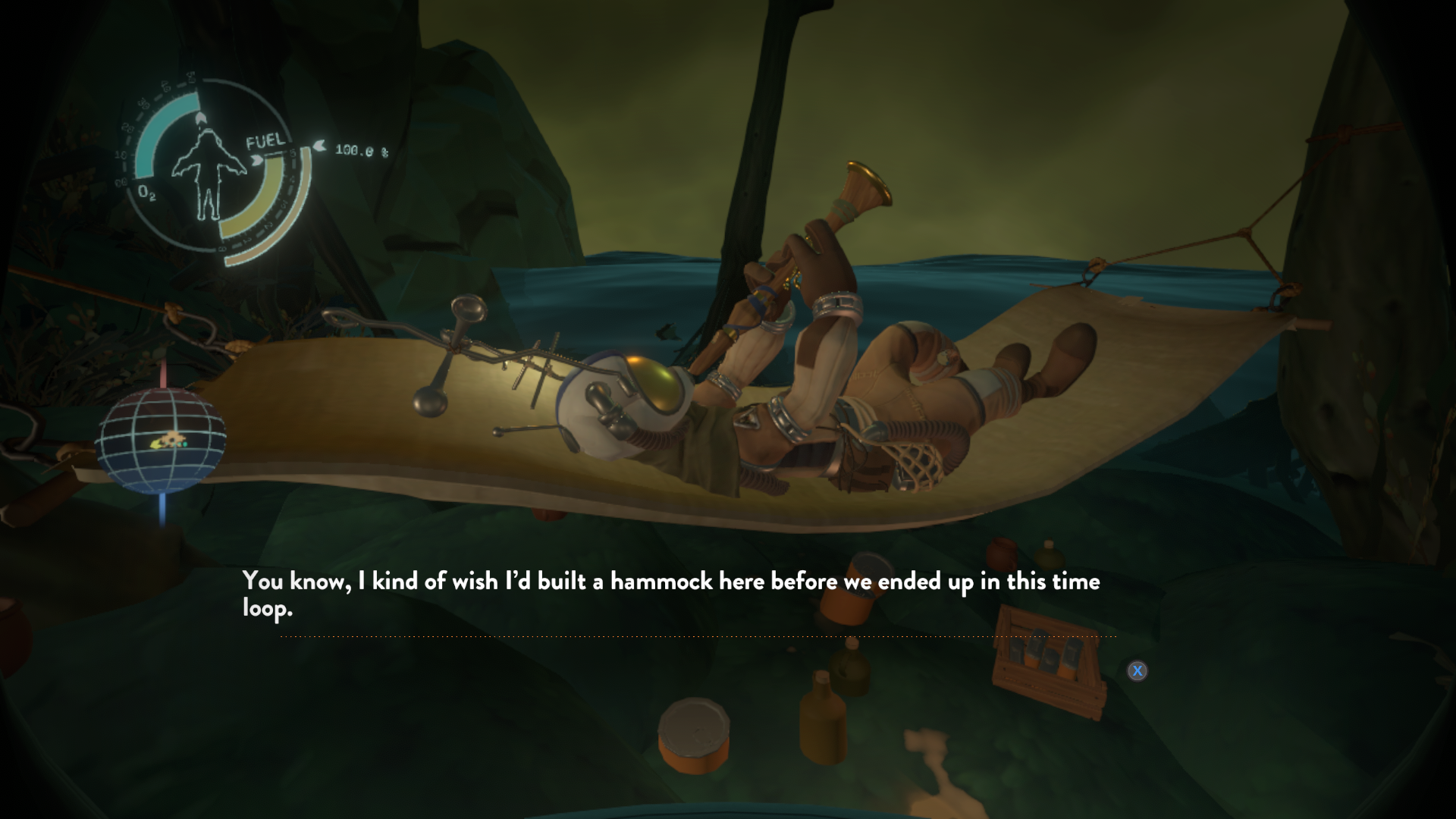Due recenti articoli pubblicati su Ludica analizzano, volutamente in chiave critica, un tema che compare sempre più spesso nelle recenti pubblicazioni videoludiche, ovvero quello del turismo. Marco Montanaro nel pezzo su Mediterranea Inferno guarda alla sua Puglia “attraverso gli occhi dei turisti milanesi che qui vengono a fotterci aria e spazio in spiaggia mentre noi, in questo reciproco gioco di seduzione, tentiamo di fregarli con le frise gourmet a quindici euro e i trulli elevati a lusso dell’accoglienza”. Gilles Nicoli invece ci parla della località delle alpi austriache in cui è ambientato Dungeons of Hinterberg come di “un gigantesco parco giochi, con guide turistiche, influencer, giornalisti, slayer principianti e professionisti arrivati per cimentarsi con i dungeon, negozi pieni di gadget e merchandising a tema, investitori pronti ad aprire nuovi hotel e ristoranti. Per la popolazione locale: un incubo; o un’opportunità”. Overtourism, gentrificazione, turismo di massa sono termini di cui si sente parlare sempre più spesso e inevitabilmente finiscono anche nei videogiochi.
In Été si parla anche di turismo, anzi forse solo di turismo. Vestiamo i panni di un pittore o di una pittrice di cui possiamo scegliere il nome e il pronome (anche neutro), che però non vedremo mai perché il gioco è in prima persona. Dalla breve ma efficacissima sequenza di apertura, osserviamo una scrivania con un passaporto, dei soldi in contanti, degli acquerelli e mano a mano che l’inquadratura si allarga, delle valigie, un cavalletto, una finestra. Fuori dalla finestra si intravede un aereo che solca il cielo, attraversa forse l’oceano e atterra a Montreal, Canada. Citando gli esistenzialisti, veniamo letteralmente “gettati” nel mondo di gioco. Abbiamo subaffittato da una certa Marianne un piccolo appartamento arredato per passare l’estate, ma appena entrati nella casa scopriamo che c’è solo un letto e che l’affitto costa esattamente tutti i soldi che avevamo con noi.
Ci ritroviamo quindi squattrinati e con un appartamento completamente vuoto (anche se devo dire molto affascinante, tutto in mattoni con una meravigliosa bow window e con inserti vetrati sul soffitto). Per fortuna Marianne ci dice come racimolare qualche soldo. Lei infatti, oltre a gestire un negozio di antiquariato (ecco dove sono tutti i mobili!) fa anche la fotografa e per un periodo ha venduto le sue foto esponendole nella vicina caffetteria. Non ci resta che sistemare il cavalletto, la tavolozza e i pennelli e dipingere il nostro primo acquerello per poi andare a parlare con il suo amico barista Théo.

Prima però bisogna trovare un soggetto da dipingere. Marianne ci invita a fare qualcosa di semplice e a portata di mano: cosa c’è di meglio di un passerotto da osservare nel vicino giardino? Ma facciamo un passo indietro. Non ho detto che la Montreal in cui ci troviamo a muoverci è completamente incolore. Semioticamente ha senso. Pensate a quando arriviamo in una città che non conosciamo: tutto è nuovo. È come se avessimo una tela bianca di fronte a noi che aspetta solo di essere riempita con il nostro sguardo: le strade che percorriamo, le persone che incontriamo, i monumenti che visitiamo, eccetera.
Il mondo di Été funziona esattamente così, si costruisce poco a poco. Dobbiamo dipingerlo a colpi di acquerello per scoprirlo e poter interagire. Inoltre alcuni oggetti verranno inseriti in un album e contrassegnati come “timbri”. È proprio grazie a questi timbri che poi possiamo andare a comporre le nostre opere. Tornando a noi, basta colorare qualche uccellino di fronte casa nostra per vederlo comparire nella sezione animali del nostro album. Quindi selezionarlo, metterlo sulla tela, personalizzarlo in grandezza, posizione, colore e quando siamo contenti del risultato confermare tutto dando eventualmente anche un nome alla nostra opera. Siamo pronti per consegnare il nostro primo quadro e ricevere una ricompensa.
Possiamo tranquillamente affermare che tutto il gameplay loop di Été si basa su questo primo esempio appena fatto. I personaggi non giocanti ci assegnano una quest che consiste nel dipingere un quadro con determinati oggetti, una volta trovati e colorati nel mondo di gioco possiamo mettere quegli oggetti sulla tela, personalizzarli a nostro piacimento e poi consegnare tutto per ricevere la ricompensa. Detto così sembra piuttosto semplice e banale ma a complicare le cose ci pensa la suddivisione temporale della giornata. Il tempo in Été è diviso in quattro porzioni: mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera. Alcuni negozi, eventi e persone sono disponibili solo in alcuni giorni e/o momenti della giornata costringendoci a tornare negli stessi luoghi spesso e volentieri.

Una volta che la giornata volge al termine abbiamo un breve lasso di tempo per coricarci nel nostro letto, altrimenti verrà fatto in maniera automatica. Al nostro risveglio possiamo decidere di impiegare la giornata come vogliamo. Possiamo fregarcene delle task che ci hanno assegnato i vari personaggi in giro per la città e pensare solo a dipingere liberamente. Oppure possiamo dedicarci ad arredare la nostra casa, a patto di avere abbastanza soldi per comprare i mobili (a dire il vero girando vicino a dei cassonetti dell’immondizia possiamo trovare anche qualche oggetto usato che la gente ha buttato via). Oppure possiamo semplicemente camminare e goderci la vivace estate di Montreal.
Certo, è difficile resistere al fascino di incontrare nuova gente ed esaudire bizzarre richieste. Ad esempio dipingere la testa di uno spaventapasseri per il proprietario del negozio di giardinaggio nel parco infestato dai corvi. O ideare una maglietta con le lettere “I Love MTL” per il negozio di souvenir, o ancora personalizzare una scatola di cereali per una mamma i cui figli non vogliono mangiare cereali salutari e noiosi. La Montreal di Été è compatta e divisa in 7 aree che sono l’appartamento, il mercato, il vicolo, il quartiere, il parco, la ferrovia e un’ultima zona che è anche al centro della mappa che si sblocca solo terminando la storia principale. Le zone da un punto di vista architettonico sono labirintiche e intricate, piene di passaggi e scorciatoie, sviluppandosi spesso anche in altezza rendendo così l’esplorazione davvero gradevole e appagante. Purtroppo se si vogliono portare a termine tutte le side quest o collezionare tutti i timbri e i colori senza andare dritti per la main bisogna prepararsi a molto backtracking.
All’inizio dell’articolo dicevo che Été parla di turismo anche se gli sviluppatori stessi lo definiscono come un gioco di pittura. Lo fa spesso in maniera indiretta e potrebbe non risultare evidente anche ai più navigati giocatori e recensori. Dietro quell’aria da wholesome game adatto solo a staccare la spina e il cervello colorando a destra e a manca e arredando il nostro appartamento, molti lo hanno snobbato. Facendone invece una lettura in chiave turistica, ci mostra come si dovrebbe vivere una città: integrandosi, coinvolgendo ed aiutando la comunità, farla crescere, spendere i soldi nelle attività locali e artigianali, lasciare un segno tangibile e positivo del nostro passaggio. L’esatto opposto del turismo “mordi e fuggi” tipico della nostra epoca.

I ragazzi del sole di Mediterranea Inferno passano solo tre giorni in quella Puglia “infestata”. Il mio alter ego ha vissuto 30 giorni virtuali (15 ore reali) esplorando e facendo conoscenza con tutte le persone che abitano i quartieri della Montreal fittizia e portando a termine tutte le quest. Alcuni giorni me la sono presa comoda e ho fatto anche della deriva situazionista, senza meta prefissata, perdendomi tra le strade. Nel suo recente libro Il videogioco del mondo (Timeo 2024) Stefano Gualeni scrive: «per quanto di natura vicaria e di breve durata, il nostro abitare questi mondi virtuali permette l’emergere di relazioni di carattere esistenziale al loro interno. Come soggetti virtuali possiamo infatti prenderci cura di altri esseri, realizzare progetti e formulare aspirazioni e speranze per il nostro futuro virtuale». Été fa proprio questo: mentre intessiamo relazioni con gli abitanti del quartiere, realizziamo anche la nostra aspirazione artistica.
Il nostro personaggio è un turista consapevole, che bazzica per i quartieri periferici invece che per i centri svuotati dagli Airbnb e le catene di negozi. Preferisce frequentare una comune arrangiata con container in mezzo ai binari dismessi della ferrovia o una caffetteria indipendente dove non dover scegliere tra Frappuccino e Salted Caramel Latte. Acquista una bicicletta usata in un’officina invece di comprarne una nuova e all’ipermercato preferisce il mercato rionale. C’è un solo hotel nel gioco e in un dialogo con un NPC proprio di fronte all’ingresso ci vengono dette queste parole: “Questi turisti pensano sempre che la città debba soddisfare i loro capricci… solo perché hanno pagato a caro prezzo una stanza pulita con le lenzuola di cotone egiziano da 800 fili! Il quartiere c’era prima dell’hotel e ci sarà anche dopo”.
Été è un gioco che trasuda arte da ogni poro, dall’anima bohémien e naïve, che sfocia un pochino anche in territorio anarchico e antiproibizionista. È un esempio virtuoso e virtuale di come passare un’estate fuori dalle rotte comuni, evitando l’overtourism, la gentrificazione, le catene di hotel internazionali, in cui si preferisce la bicicletta a Uber, si interagisce con la gente del posto invece che con guide turistiche microfono in mano e bandierine alzate che ti fanno seguire percorsi battuti come soldatini. Si respira un vero senso di libertà e di scoperta, che è quello che dovrebbe offrire una vacanza estiva. Nessuna costrizione, nessun orario da rispettare, nessuna pressione, nessun fallimento, nessun giudizio. Solo una città da scoprire, gente con cui interagire, tante tante tele da dipingere.
Questo articolo è apparso su Ludica